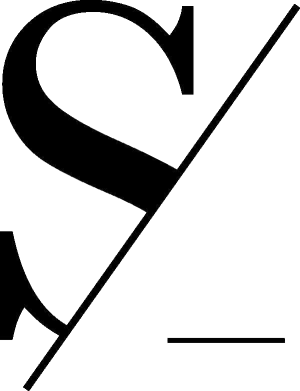Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista Toylet Mag, nell’estate del 2012: dieci anni dopo, per celebrare il ritorno del Primavera Sound dopo lo stop pandemico, eccolo.

La domenica mattina, a Barcellona, le strade sembrano costruite tra cartonati esenti da ogni forma di vita. Eppure, basta proseguire la propria corsa verso l’aeroporto e infilarsi in metropolitana per rimanere incastrati in una moltitudine di individui, segno distintivo di quanto si sta concludendo.
In una città che si divide tra gli spettri della crisi globale e il fascino vibrante della vita culturale, il Primavera Sound resta uno dei festival da marchiarsi a fuoco sulla pelle, uno dei migliori nel panorama europeo dove già spiccano nomi storici come Reading o, dalla parte opposta del continente, Sziget, senza dimenticare la moltitudine di raduni tra che fermenta tra i due poli.
Di anno in anno, la line up del Primavera non solo getta addosso al suo pubblico un amalgama di suoni che trapassa parte a parte orecchie e anima, ma è anche in grado di coniugare le emozioni più profonde con gli strumenti di chi, della musica, ne fa il proprio lavoro: così, etichette indipendenti, riviste, artisti affollano i palchi e gli eventi dedicati agli operatori del settore.
E questo solo per tracciare pochi contorni.
La prima invocazione che sorge spontanea nel valicare i chilometri di transenne del festival, che quest’anno mette dodici sigilli alle sue edizioni, è quella rivolta all’ottenimento dell’ubiquità, soprattutto dopo settimane passate a evidenziare un programma che è un vero e proprio catalogo della musica contemporanea (nonché preludio alla nuova stagione).
Il loop di concerti inizia già nella serata di mercoledì, quando alcune band, tra le quali Black Lips e Wedding Present, si esibiscono in città, presso l’Arc de Triomf.
Ma è l’ultimo giorno di maggio quello dell’inizio ufficiale degli eventi, con Baxter Dury ad inaugurare il main stage e la trinità monolitica della serata, composta da Afghan Whigs, Wilco e Cure.
È proprio il gruppo di Greg Dulli, di nero vestito e in ottima forma, a esibirsi mentre il sole tramonta sul Mediterraneo, in grado di riempire l’atmosfera con un impatto sonoro avvolgente, dove la sezione ritmica sorregge linee di chitarra dense, spazzando via ogni nostalgia per dare al presente una formazione perfetta e vitale. Nella scaletta, inaugurata con Crime Scene, Part One, compaiono anche un paio di cover, tra cui la Lovecrimes di Frank Ocean, mentre il concerto fluisce lentamente sul finale di Miles Iz Ded. Più che una reunion di dinosauri, il concerto risulta un auspicio per la pubblicazione imminente del nuovo disco, che è solo possibile sperare intriso d’adrenalina tanto quanto l’esibizione di stasera.
Di recente passati per Milano con uno show che ha riassunto in sé tutta la storia della musica recente, i Wilco sembrano invece minuscoli nell’ampiezza del festival, forse limitati nell’interazione con l’impianto. Meglio piuttosto essere tra i fortunati incappati nel loro set acustico in un negozio di dischi della città, qualche ora prima, con poche decine di ascoltatori in un eden musicofilo.
D’altro canto, Alex Kapranos ha qualche problema alla voce e non lo nasconde. Eppure, i Franz Ferdinand si rivelano una band a iniezione, che macina il set con picchi vitali nelle pietre miliari della propria discografia: il sound è grezzo e le ritmiche sono vorticose, tra This Fire e The Dark Of The Matinee, gli scozzesi praticano la filosofia dell’entusiasmo, liberando la propria musica dai vincoli talvolta troppo stretti del supporto magnetico.
A pochi passi dal main stage, tuttavia, si schiude una nuova dimensione: proprio sulla costa, il Mini Stage ospita, tra i tanti, Death Cab For Cutie e Beirut. Mentre il sole tramonta durante la performance di Ben Gibbard e soci, Zach Condon incanta con la semplicità di chitarre e ottoni, quasi cristallizzando l’aria intorno in una dimensione senza tempo. E non può mancare l’antitesi a questa quiete, più precisamente nella persona di Mark Arm. I Mudhoney si infilano in effetti tra coloro che, per decenni, hanno impartito lezioni a suon di plettri e corde vocali e che si dimostrano in grado di continuare, basti pensare alla catartica Touch Me, I’m Sick.
Poco dopo, su un altro palco, compaiono i Kleenex Girl Wonder che, intorno alla figura di Graham Smith e del suo basso senza paletta, fanno rivivere un lo-fi grezzo, ammansito da melodie dirette, come quella di In This Way.
Il secondo giorno, quando la giornata inizia sapendo che i Melvins non saliranno mai sul palco e che, in molti, avranno probabilmente perso l’unica occasione di rivederli on stage, cercare la prima consolazione disponibile è quasi fisiologico (sensazione già avvertita all’annuncio del forfait europeo di Björk).
Così può capitare che, mentre si discorre dell’argomento in coda alla cucina tex mex del festival, capiti davanti a te un tizio in giubbotto di pelle, con un fiore giallo nel taschino: tra le personalità artistiche che più si avvicinano al concetto di divino, Warren Ellis si aggira per i concerti e non disdegna una chiacchierata sulla sua esibizione dello scorso anno: nella passata edizione, Ellis era infatti sul palco accanto a Nick Cave, con i Grinderman. “Quale delle centinaia di concerti che ho fatto? Ah questo di Barcellona! Sì, è stato incredibile”, risponde lui mormorando con tranquillità dietro la barba arruffata.
L’apoteosi virtuosistica della coppia, durante quel concerto, era culminata in una capriola da acrobata dello stesso Ellis, tirato a terra da Nick Cave durante una vorticosa danza sabbatica. Quest’anno, il barbuto artista si esibisce con i Dirty Three: dalla voce che graffia la notte agli accordi del suo violino, è la sua personalità a calamitare l’attenzione, ma la serata è solo all’inizio.
Il boato deve ancora deflagrare in tutti i suoi decibel. Contravvenendo alle regole del sano snobismo che, rispetto ai grandi festival, vuole le esibizioni dei diversi artisti non essere dei veri concerti, Robert Smith e compari non danno un vita a un live stantio: si cimentano in oltre tre ore di suoni, riesumando la completa discografia e lasciando sulla propria strada brani indelebili.
Quella di Barcellona è, per Robert Smith, la seconda data del Summercure Tour dopo quella del Pinkpop, nei Paesi Bassi, di qualche giorno prima. Qualsiasi canzone abbia contribuito a fare della band inglese un’icona del post-punk e della new wave, fondendo l’abilità cantautoriale di Smith con la ricerca sonora e melodica, questa sera splende intensa come non mai, toccando vertici come l’improvvisazione all’acustica su A Forest. Ma compaiono anche brani come Dressing Up, abbandonata in un angolo sin dagli anni ’90 o, ancora più indietro nel tempo, un aversione di Fight in grado da far vibrare ogni singola cellula, suonata per l’ultima volta più di un quarto di secolo fa.
I Cure tornano sul palco tre volte alla fine del proprio set, accomiatandosi su Boys Don’t Cry e spazzando via, in un soffio, i pochi fortunati ad esibirsi in contemporanea, eclissati da un profeta.
Affrontare con l’immagine di Robert Smith e soci impressa nella mente l’ultimo giorno di festival, non è facile.
Presso il palco di Pitchfork compaiono i Chromatics, voce suadente e beat elettronici, forse con un sound troppo disperso nel vento marino per far apprezzare appieno la loro grinta raffinata. Non manca poi la dimensione ultraterrena ricreata dalla voce di Josh T. Pearson, racchiusa tra le pareti dell’auditorium antistante il festival. Poco prima della mezzanotte, la sua figura esile si accinge a firmare dei poster realizzati a mano tra gli stand del festival e scambia alcune parole con chi fa lui compagnia, lo sguardo sempre fisso su un punto lontano e la gentilezza nella stretta di mano. Impossibile dimenticarlo in un house concert milanese dove, con la semplicità delle sei corde e la sua vocalità, è stato in grado di elevare delle vere e proprie preghiere profane: oggi, non solo il ricordo della sua voce è straniante, ma lui stesso è uno spettro che vagola tra il cemento del Parc del Fòrum.
La sigla definitiva del Primavera Sound diventa reale con l’esibizione dei Justice, troneggianti sul loro altare di led e amplificatori Fender, in grado di passare dagli attacchi in cassa distorti di Water of Nazareth all’ormai conclamato inno We Are Your Friends di Simian: bpm che s’infiltrano direttamente nei polmoni per pervadere chiunque, dando vita a un immenso dancefloor, nella tribalità del ritmo.
Può apparire la più banale delle ovvietà sostenerlo, ma i concerti e gli istanti sono troppi per essere ricordati tutti: dai Refused che tornano sulle scene lasciandosi dietro schiene marchiate da piedi durante improvvisati crowd surfing, all’incredibile vocazione melodica di Sleepy Sun e Beach House, in una coesistenza di contrasti che continua con Napalm Death e Field Music, e ancora con i Girls e le loro coriste, scorrendo all’infinito il carrozzone catalano. È Yann Tiersen a spegnere le luci, con un concerto in piazza la domenica sera, quando chi scrive avrà già disfatto la valigia e riempito la lavatrice.
Oltre a districarsi tra i grandi nomi degli ultimi 30 anni di musica, le band che fanno schizzare le medie di Pitchfork alle stelle e i nuovi arrivi, il Primavera si svincola dalla sua location per affondare anche in giro per la città, con decine di eventi.
E per far capire, se ce ne fosse bisogno, in che modo la musica la si può respirare.
Intervista a Boxeur The Coeur
Il Primavera Sound resta un’occasione di confronto preziosa e, così, può capitare di incappare in un cocktail ed essere rapita da beat elettronici in grado di invischiare anche l’ascoltatore più distratto. Può capitare, sempre in quell’occasione, di cercare con lo sguardo un dj, magari di quelli intravisti in un locale berlinese, e invece ritrovarsi faccia a faccia con Paolo Iocca, già Franklin Delano e oggi Boxeur The Coeur.
Il tutto durante un incontro emblematicamente titolato Italian Sound Renaissance.
Cosa rappresenta per te suonare qui, a Barcellona?
Mi aspetto di avere un buon riscontro dal pubblico che sarà lì e da eventuali addetti ai lavori che possono darmi una mano a portare il mio progetto all’estero: questo è quello che spero, senza farmi troppe illusioni.
L’Italia è molto ricettiva rispetto ai progetti stranieri, di ogni genere. Ma come vedi la scena italiana in rapporto all’estero?
Tenderei a stare sul generico e direi che ultimamente c’è molto fermento nella parte della musica esportabile all’estero, cioè quella musica che ha una freschezza, una ricercatezza e un livello di qualità e sperimentazione negli arrangiamenti musicali che può essere proposta a livello internazionale.
A proposito di questo, cosa mi puoi dire del tuo ultimo disco?
Il lavoro è nato in completa solitudine, poi mi sono aperto a un aiuto esterno, quello di Shannon Fields, che mi ha aiutato proprio nel concepire gli arrangiamenti, lo stile, a farmi crescere in qualche maniera con uno sguardo esterno e tecnico che poteva essere più lucido del mio.
Il disco in realtà non è nato per essere suonato da solista in veste elettronica, anche se c’è molta elettronica rispetto ai miei lavori precedenti con gli altri progetti: la cosa buffa è che il live è una reinterpretazione a volte abbastanza vistosamente diversa di alcuni brani e… sembra che stia funzionando e sto ricevendo critiche più positive per il live che per il disco! Questo mi rende davvero contento perché secondo me il live è la prova del nove per ogni artista.
E hai dovuto reinterpretare molto i brani rispetto al disco, nel preparare i live?
Diciamo che ho sfruttato i limiti e li ho rigirati a mio favore, in qualche maniera. Ho deciso di riconcepire i brani, di riarrangiarli e svilupparli in modo diverso. Il lavoro di ricampionamento e rilooppaggio dei brani mi ha dato nuova creatività perché alla fine ho scoperto suoni che in realtà nel brano intero non si sentono perché magari sono un po’ sommersi, ma aggiungono quel poco perché da soli hanno la loro bellezza. Quindi ho ricostruito interi brani da quei loop o da quei campioni che erano in secondo piano, a volte partendo con un giro che nessuno riconosce e poi pian piano ci costruisco quel brano che, chi ha ascoltato il disco, riconosce solo dopo un po’. C’è anche questo effetto sorpresa e questa sorta di remix che faccio durante il live.
È una concezione molto artigianale del fare musica e del manipolare il suono!
Sì assolutamente, poi filtro tantissimo in tempo reale, suono cose, le metto in loop, c’è una parte improvvisativa molto estesa durante il live che può avvenire in modo diverso di momento in momento. Quasi la metà del set che ho appena fatto era improvvisazione e non parte del disco e, mentre suonavo, sentivo il calore del pubblico che mi arrivava.
Il live resta il momento in cui il musicista si fa valere e dimostra di essere un bravo artista, che poi suoni elettronica o una chitarra non importa: devi dimostrare di essere bravo, perché tutti oggi sono in grado di fare un disco, con il digitale e l’autotune. Inoltre, è molto più facile fare una cosa banale con l’elettronica, perché ci sono moltissimi preset che è possibile utilizzare.
Come mai hai deciso di intraprendere la strada dell’elettronica?
Non ho mai fatto elettronica in vita mia e ho iniziato con questo lavoro! È da parecchio tempo che sono appassionato di dance music, non sono un cultore, ma mi piacciono quei suoni e quella cultura mi attira molto. Poi anche in passato ci sono stati periodi in cui ascoltavo solo black music, elettro funk, hip hop. Un po’ questa cosa ce l’avevo dentro e cercavo di tirarla fuori già nel primo periodo dei Blake/e/e/e. Ero un appassionato delle cose più elettroniche che abbiamo fatto negli ultimi live ed è questo lato che poi è sfociato in questo lavoro.
Intervista a Francesco e Giuseppe di Ghost Records
Sempre in occasione del Primavera Pro, la rassegna dedicata espressamente agli operatori del settore, è possibile incontrare vecchie conoscenze, come i “fantasmi” di Ghost Records, l’etichetta varesina che nell’ultimo decennio ha dimostrato come sia possibile coniugare la proposta di scelte musicali di qualità allo stare a galla in un music business sempre più spietatamente affollato.
Cosa rappresenta per voi il Primavera Sound?
Giuseppe – Da tre anni a questa parte il Primavera è diventato per noi un appuntamento fisso. L’inizio del festival coincide con la chiusura della stagione concertistica del Twiggy Club. Quindi rappresenta una sorta di vacanza-lavoro, perché dalla musica, soprattutto dal vivo, non vorremmo staccarci mai.
Francesco – Inoltre Barcellona è una città stupenda. Ci sono appuntamenti per noi ormai rituali: il pranzo come mio fratello e sua moglie (che vivono li da anni), il ritrovare tanti amici che magari fatichiamo a vedere durante l’anno, la possibilità di vedere le migliori band emergenti e quelle che hanno formato la nostra cultura musicale negli anni ‘90.
Con quale obiettivo approdate qui ogni anno?
Giuseppe – L’obiettivo è sempre lo stesso: divertirsi, ascoltando ottima musica in una location e con un clima, anche in senso lato, unici.
Francesco – Si riesce anche a scambiare qualche opinione con operatori del settore: etichette, booking agent, agenzie di PR, per “tastare” il clima generale, per capire le band che potrebbero funzionare dal vivo in Italia, o semplicemente quelle da non perdersi sul posto.
Quali artisti avete scoperto lì ed eventualmente “portato” in patria?
Giuseppe – Penso che il SXSW e il CMJ siano festival più adatti del Primavera Sound per scoprire nuovi gruppi. Negli anni scorsi abbiamo scoperto ad Austin e New York diversi gruppi, che ci sono piaciuti tanto da decidere di portarli a suonare al Twiggy Club.
Francesco – Per sua struttura e fisionomia, il Primavera non è il luogo più adatto per scoprire nuovi talenti. Il cartellone è ricco di band che non vuoi/puoi perderti: quelle da scoprire sono lì fuori, dietro casa, oppure nel angolo più recondito del pianeta. Anche se da quando è stato istituito il Primavera Pro (la sezione dedicata agli operatori del settore discografico e dell’intrattenimento musicale), si sta rafforzando l’idea di creare una sezione del Festival più “business oriented”. Anche dall’Italia si è iniziato a muoversi: sarebbe però auspicabile che a rappresentare il nostro Paese all’interno del Festival non venisse seguita la solita logica del “quartierino”, ovvero del chi prima arriva meglio alloggia, ma piuttosto ci proceda coscienziosamente e su di una base di consenso più estesa, e privilegiare le realtà più meritevoli e – soprattutto – esportabili del nostro panorama musicale.
Toylet Mag, estate 2012.
Immagine in apertura dalla pagina Facebook del festival: i Justice sul palco del Primavera Sound 2012 © Eric Pàmies.