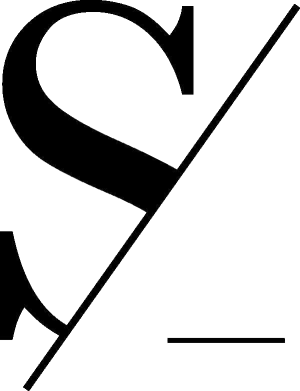Capitale della ribellione e delle creatività, dell’affermazione identitaria dei punk così come delle ultime tendenze, la città tedesca è simbolo della corsa verso il domani, una realtà da afferrare e in continuo divenire. È qui che i grandi talenti hanno contribuito a cambiare il rock, dove le luci non si spengono mai e il futuro già presente.
A ppena i piedi lasciano la scaletta dell’aereo per sfiorare la terra berlinese, la sensazione si fa chiara: qualunque cosa accadrà e che, in qualche modo, avrà che fare con questo posto, lascerà il segno per sempre.
Berlino è contraddittoria, sfuggente, variegata, tesa ogni secondo verso la vita, dove tra rovine confuse è possibile scavare spazi per realizzare idee mai viste prima. Sa essere fredda, tagliente, troppo veloce da seguire ma anche in grado di lanciare lì davanti a te qualsiasi cosa serva e, al momento dell’arrivederci, di aver forgiato un’anima più ricca di quando non vi sia approdata.
Oggi è il pantheon di più e meno giovani creativi, la meta low cost dei mille divertimenti, piena di ristoranti, droghe e mostre per tutti i gusti. In queste vie la storia, quella viva, fatta di luoghi e di persone riflesse ogni giorno nelle acque torbide dello Spree e sulle vetrine dei negozi, da anni vive quotidianamente un processo di creazione inarrestabile.
E non potrebbe essere altrimenti, in un una città che ne ha attraversate di tutti i colori, dallo splendore delle avanguardie agli inizi del 900, a centro nevralgico del disegno di onnipotenza di un regime assolutista, per finire come ammasso di resti devastati alla fine della guerra; poi liberata, divisa, occupata, sviscerata senza un attimo di tregua. Forse così i berlinesi hanno imparato che dalle macerie si può plasmare la vita, mettendo in pratica l’insegnamento con uno spirito in bilico tra la speranza nel domani e un edonismo necessario alla sopravvivenza, restaurando case e giardini, sfogando la creatività tra musica, teatro, cinema, lettere, arti figurative e quant’altro.
Certo, dopo la divisione in settori avvenuta alla fine della Guerra Mondiale, non è facile convincere i tedeschi a starsene in balia degli eventi nelle vie cittadine. Tra gli incentivi, oltre alle agevolazioni edilizie, è particolarmente interessante per i giovani residenti nel settore Occidentale l’esenzione dal servizio militare: è il primo ingrediente per quel che diventa un rifugio per gli spiriti più freschi e liberi, un’isola di progressismo con la morsa sovietica intorno e tutti i problemi del caso, ma dannatamente vivace.
D’altro canto, nella DDR, il regime non dimostra proprio di gradire che le regole vengano trasgredite, facendo uscire dai cardini gli ingranaggi di un sistema tentacolare. Proprio questo ha consentito il fiorire di una vera cultura d’opposizione, un movimento sotterraneo che di tali principi se ne infischia, finendo ad ingrossare le liste dei sorvegliati speciali della Stasi, la polizia segreta, e vivendo con le spie alle costole ventiquattr’ore al giorno.
Grazie alle onde medie, per i giovani dell’Est, a Berlino come a Dresda o a Lipsia, è possibile captare la lezione della ribellione inglese. A un’ideologia imposta dall’alto che cancella l’individuo, i punk a metà anni 70 oppongono la libera espressione di idee, l’affermazione delle personalità distinte, il diritto a un’arte senza censura. Identificati e schedati, dai musicisti ai pittori passando per i poeti, la loro irruenza resta l’unica soluzione per tentare di far breccia in un sistema tanto rigido e in un’opinione pubblica ad effetto permafrost. Più che i contenuti e le filosofie dei punk, tuttavia, ciò che più spaventa i piani alti sono i contatti con l’Occidente: uno scambio che rappresenta il fianco debole in un disegno ben più ampio e che non prevede interferenze. Quasi paradossalmente, questi fuorilegge a tutti gli effetti trovano la lealtà in un’aspettata sostenitrice: la Chiesa ortodossa, anch’essa osteggiata dalla Repubblica Democratica, alla quale si devono concerti, spazi espositivi, il supporto al coinvolgimento dei punk nelle lotte e nelle manifestazioni per le rivendicazioni dei diritti civili. Questo è lo scenario del sottofondo distorto della controcultura targata DDR, che fa sentire a tutto volume la sua rabbia, evolvendo la lezione dei maestri britannici e mettendo in gioco persino la libertà personale. Non sono pochi infatti quelli finiti dietro le sbarre, compresi giornalisti occidentali arrivati sin dall’altra parte del muro, con tanto visti speciali, per documentare il fenomeno. E i suoi rappresentanti sono tanto schietti da essere ancora oggi attivi e apprezzati a livello mondiale, come la pittrice Cornelia Schleime che, prima di scappare a Ovest e ricominciare la sua vita da zero, ha militato nella band punk seminale Zwitschermaschine.
Quando il muro viene giù, l’unione tra due poli tanto opposti è in grado di generare una supernova mai vista prima in Occidente per coraggio e anticonformismo, più volte sul punto di scoppiare in un caos irreparabile e, invece, finita col diventare il simbolo di libertà per eccellenza, il centro del mondo dove tutto è possibile, come prevede il protagonista del film Goodbye, Lenin!.
Oggi, per andare da un locale all’altro tra quartieri tanto vicini come Kreuzberg e Friedrichshain, è sufficiente farsi una passeggiata sotto le arcate dell’Oberbaumbrücke, ma fa salire un brivido tra le vertebre pensare che queste due zone siano state letteralmente spaccate in due: la prima a Occidente, la seconda sotto l’influenza sovietica. Quel muro c’è ancora, fa parte della East Side Gallery, e adesso Kreuzberg sfoggia con orgoglio la sua anima ribelle, ridotta in passato a quartiere periferico e per questo focolaio di contestazioni da parte dei suoi abitanti, raccoglie le anime più diverse, dai radical-chic agli emigrati turchi e italiani, per arrivare ai punk contemporanei, in un crogiolo di piccoli negozi di dischi e isolate librerie. A Friedrischain, invece, appena dietro i monolitici palazzi di Frankfurter Allee e Karl-Marx-Allee, case occupate e squat sembrano ricordare le ferite della disperata ricerca di libertà tra il cemento del regime, mentre laboratori artistici spuntano tra i cavi di vecchie industrie ormai abbandonate, impossibili da scovare senza affidarsi a chi lì ci vive.
“Ich bin ein Berliner”: gente che va e gente che viene
Mentre il punk tenta in tutti i modi di infrangere le barriere a Est, alcuni degli artisti più significativi della musica contemporanea concepiscono le proprie opere nel settore occidentale, andando a influenzare sia la loro discografia sia quella delle generazioni successive. Il catalogo di quelli passati sotto il cielo di Berlino è sterminato, i soli muri degli Hansa Tonstudios sono tappezzati di foto ricordo, c’è poi chi qui ci ha vissuto, chi semplicemente è rimasto incantato dallo scorrere delle luci fuori dei finestrini e chi è stato frastornato dal fumo denso nei locali notturni. Alcuni di essi, combinando il talento all’alchimia di questo luogo, lasciano un’impronta indelebile.
Tanto per cominciare, quando la loro macchina punta verso nord-est, sanno entrambi che laggiù non ci sarebbero finiti per caso. Le registrazioni di The Idiot di Iggy Pop sono terminate da poco e quel disco ha già il sapore della rivoluzione, ma ci vuole qualcosa di ben più grande per David Bowie, che arriva da una Los Angeles dove ha toccato il fondo per scavare ancora più giù, sguazzando tra alcool e droghe, dopo aver trascorso anni della sua vita tra studi di registrazione e tour, in un turbine confuso di vertici estetici e dilaniamenti esistenziali. Già durante i concerti dello Station To Station Tour, la band di supporto viene sostituita dal sound di Radio-Activity dei Kraftwerk, un disco che ha calamitato l’interesse del profeta del glam rock verso un mondo estraneo, colto e affascinante. D’altro canto, egli non avrebbe potuto non intercettare le sperimentazioni di band quali Faust o Neu!, il cui ’75 diviso in due lati, uno strumentale e l’altro decisamente più viscerale, visto a posteriori già prelude le strutture di Low e “Heroes”, pubblicati nel fatidico 1977. Ma c’è qualcosa che ha già attecchito più nel profondo dell’anima dell’artista, come una passione per l’espressionismo tedesco nata da ragazzino.
In Germania, inoltre, i musicisti hanno imboccato una direzione piuttosto particolare nelle loro ricerche, basti pensare allo Zodiac Free Arts Lab, fondato nel quartiere berlinese occidentale di Kreuzberg da Conrad Schnitzler, Hans-Joachim Roedelius e Klaus Schulze, polo riassuntivo della musica d’avanguardia e psichedelica, guardato con riverenza dal resto del continente e non solo, così come le realtà da lì sgorgate: oltre ai Kraftwerk, Cluster e Tangerine Dream.
Negli anni 70 tuttavia i fautori della Kosmische Muzik registrano perlopiù a Colonia e la vocazione tecnologica di molti artisti trova terreno fertile a Düsselforf, eppure Bowie punta dritto al cuore berlinese, dichiarando chiaramente il motivo a Vogue nel 1978 e citando la figura di uno scrittore e futuro premio Nobel per la letteratura:
La penso allo stesso modo di Günter Grass, e cioè che Berlino è il centro di tutto ciò che sta succedendo e succederà nei prossimi anni in Europa.
— David Bowie
Insomma, egli sembra già rapito dall’ambiguità del luogo, con focolai di ribellione a squarciare l’alone di malinconia, una città talmente presa a guardare avanti che a nessuno importa chi sei o come ti vesti, neppure se ti trucchi o crolli impregnato d’alcol in mezzo alla strada.
Una volta messo piede qui, David Bowie inizia il suo sodalizio con “l’architetto sonoro” Brian Eno: è lui l’uomo ideale per la nuova vita, quella che ha preso il via dopoaver messo fine agli eccessi del glam, spazzando via i lustrini per far posto all’espressione di una coscienza più intima e oscura.
La vita nella capitale tedesca, l’incontro con uomo in grado di creare strutture sonore inedite e, non ultime, le sonorità degli Hansa Tonstudios sono tutti elementi che vanno a confluire nella trilogia berlinese composta da Low, “Heroes” e Lodger, tutta linfa vitale per un nuovo corso artistico, così fondamentale che lo stesso creatore lo ribadisce nel 2001 sulle pagine di Uncut, sostenendo che “Tutto il mio essere è in quei tre dischi. Sono il mio DNA”. E l’impatto degli album oltre i confini tedeschi è considerevole: Howard Devoto, fondatore dei Buzzcocks, considera i primi due capitoli indescrivibili per l’influenza che hanno su di lui, colpito dal minimalismo a fronte degli eccessi nel rock degli ultimi anni, compresi i meandri insondabili della psichedelia. In più lo lascia senza fiato la presenza dell’elettronica, così puntuale e indispensabile nel creare le atmosfere.
Basta lasciare da parte per un attimo i dischi di Bowie e ascoltare la voce della Baby di Iggy Pop per incappare in qualche similitudine col primo capitolo della trilogia berlinese, ma è Lust For Life ad essere realizzato a Berlino. Il Duca Bianco ha salvato l’icona americana del punk dall’andazzo preso con gli Stooges e lo ha preso sotto la sua ala protettiva, conducendolo musicalmente in un nuovo territorio dove abbandonare le ruvidezze alla Raw Power in favore di una dimensione vocale inedita, nonché di una creatività sonora più articolata, tanto inaspettata da spiazzare non più solo Devoto ma l’intera sua nuova band, i Magazines che, non appena scoprono quel che ha combinato l’Iguana, cercano di lavorare con gli stessi tecnici.
Per gente come loro, insomma, Berlino è ben altro che una speranza di ritrovare se stessi e ricominciare: è il pulsare della vita stessa con un battito diverso, una nuova arte.
Certo è più facile trovare nuovi stimoli quando si fugge da un contesto che ha ben poco di idilliaco, quantomeno si ha l’impulso di ricominciare da qualche parte. La potenzialità della città appaiono tanto più forti quanto più essa infonde la carica anche in chi qui ci nato e vissuto, e vive la presenza di un muro grigio alto più di tre metri e mezzo come scontata. Più volte Blixa Bargeld osserva tra le pagine di quotidiani come Der Spiegel che “Trovare dei detriti urbani è possibile in qualunque città occidentale” e come dargli torto: lui a Berlino Ovest ci è nato nel mezzo degli anni 50 e quella è stata da sempre l’unica realtà con cui confrontarsi. Ma una spiccata sensibilità non può che aiutare a notare come la città viva una situazione del tutto unica e, di conseguenza, cavarne tutto il buono:
Potevi letteralmente vivere senza soldi, c’erano un sacco di case occupate e ci ho vissuto anche io. Era impossibile trovare un appartamento. Ma non dovevi entrare nell’esercito e questo ha fatto confluire un sacco di gente a Berlino Ovest: una volta arrivato qui, non ti saresti dovuto arruolare mai più. Era una specie di utopia per i più insoliti, c’erano dozzine di band e tutte queste esistevano in media una settimana.
— Blixa Bargeld
Discorso che non vale per la sua, gli Einstürzende Neubauten, letteralmente “nuovi edifici che crollano”.
Prendendo le mosse, ancora una volta, da archetipi come Can, Kraftwerk e Neu!, così come dalle complessità strutturali dei Pink Floyd, Blixa inizia ad approcciare la musica. Una devozione all’arte come la sua non può non attecchire in un contesto tanto atipico e fertile come quello berlinese. Qui gli artisti, soprattutto quelli che si identificano con il movimento Die Geniale Dilettanten (“I dilettanti geniali”, per l’appunto) si spingono sempre più oltre i canonici confini, si liberano dai vincoli dei quattro quarti e tentano di superare la classica formazione composta da chitarra, basso e batteria: l’idea è quella che tutto sia possibile.
Sperimentazione allo stato puro, forza espressionista, ispirazione dadaista e musica nel senso primordiale del termine sono i cardini sui quali ruotano le origini degli Einstürzende che, già prima dell’esordio con Kollaps nel 1981, creano qualcosa di unico, irripetibile come le prime esibizioni che si configurano in atti unici, happening estremizzati dove sono le forti emozioni con cui gli spettatori vengono scossi, come da manuale brechtiano, a far crollare gli ambienti circostanti, spesso location industriali in disuso. Basti pensare all’Untergang Show del quale sono protagonisti nel 1980 e che ha luogo in un vecchio mattatoio, poi diventato simbolo dell’avanguardia.
Gli strumenti nascono da rifiuti della moderna società per diventare protagonisti di un vero e proprio blues urbano: martelli pneumatici, vecchi transistor, materiali di ogni genere da assemblare e sui quali impiantare melodie e arrangiamenti, con un parco strumentale potenzialmente infinito tanto quanto i sentimenti suscitati in chi ascolta.
Così come la materia musicale si plasma in modo differente, l’opera della formazione è in continua evoluzione, anticonformista e avanguardista nel vero senso della parola, dalle sonorità industriali esplora l’elettronica, studia la forma canzone spezzandola e ricomponendola, rivaluta continuamente gli strumenti e incrocia sul suo cammino una miriade di collaborazioni, come quella con Diamanda Galas. Ma ce n’è una che traccia un profondo solco nella musica degli ultimi decenni: quella con l’australiano Nick Cave. Lui a Berlino trova il suo opposto e complemento, con la personalità eclettica di Blixa fonda un unicum irripetibile e, quando Cave canta ancora nei Birthday Party, il genio tedesco già compare alle chitarre di Mutiny In Heaven. La band, infatti, ha base in Europa fino al suo scioglimento nel 1984, ma proprio dalle sue ceneri prende vita la formazione dei Bad Seeds, dove lo stesso Bargeld resta fisso per due decenni e il suo alone si fa notare già nel debutto di From Her To Eternity: le sei corde fendono le atmosfere con un impatto sonoro denso e vivido, la voce stessa di Cave trasporta in una dimensione superiore, un’esplorazione più intima e cupa a toccare le corde nascoste del suo essere. Nascono nel ventre della città tedesca anche gli album The Firstborn Is Dead, Kicking Against The Pricks, You Funeral… My Trial e Tender Prey e Cave ci resta fino a poco prima del crollo del muro, per poi comprare un biglietto per il Brasile e trasferirsi laggiù.
Mentre Germania Ovest e Australia danno vita a un sodalizio tanto sorprendente, nell’Inghilterra di Basildon c’è chi sembra decisamente interessato agli esperimenti sonori con gli E-mu Emulator e synclavier presenti agli Hansa. Per i Depeche Mode è il momento di studiare il terzo disco e di capire quale direzione prendere ora che stanno crescendo. Anticipando i connazionali Marillon, che finiranno a Berlino per il loro Misplace Childhood, Alan Wilder rispolvera il culto personale per la trilogia di Bowie e i leggendari studi hanno dei costi decisamente contenuti: tutti elementi che fanno optare per una trasferta teutonica verso quella che sembra una terra promessa.
L’impressione nell’immagine dei giovani Depeche Mode che sbarcano in città sfiora la tenerezza, considerata la caratura dell’avanguardia berlinese e lo spessore dei personaggi che bazzicano l’ambiente, squat compresi, poco inclini a saltellare sulle note di Just Can’t Get Enough. Secondo Daniel Miller, produttore e fondatore della Mute, che lo racconta anche nella biografia Black Celebration, “I Depeche Mode erano ovviamente molto più pop della maggior parte dei musicisti con cui uscivano a Berlino, ma la gente li ammirava perché aveva capito quel che stavano facendo. Stavano facendo musica pop sperimentale. Alcuni avevano un atteggiamento un po’ snob, ma generalmente li accettavano per esser parte della gente di lì”. E lì ci stavano decisamente bene: Andrew Fletcher pensa di titolare la sua personale etichetta Toast Hawaii, rendendo omaggio al sandwich ananas e formaggio che divora ogni giorno, Martin Gore alla fine ci si trasferisce pure e tutti quanti sono frequentatori di un noto club, lo Dschungel. Inoltre, il gruppo riceve spesso visite da gente come gli stessi Einstürzende Neubauten o Chrislo Haas, tutti personaggi che avrebbero trovato meglio da fare se non avessero pensato che quegli inglesi stessero combinando qualcosa d’interessante durante il loro soggiorno.
Proprio agli Hansa avviene il mixaggio di Construction Of Time Again ed è registrata parte di Some Great Reward. Al fianco di Daniel Miller c’è Gareth Jones, noto nell’ambiente industrial per i suoi tocchi rumoristici ed espedienti tecnici, il cui primo lavoro è in veste di tecnico del suono per il brano Everything Counts, che già marca una sostanziale differenza nella produzione precedente della formazione, così come basilare sarà, tra le altre sue creature, People Are People.
Testimonianza del loro passaggio restano dei video come quello, appunto, di Everything Counts e il promo di Master And Servant, considerato da Wilder come vincitore del premio per la coreografia più imbarazzante, un’idea geniale di Fletcher.
Anche Black Celebration ha un’ispirazione tutta berlinese: nasce da un’idea che si rifà al regista Werner Herzog e viene mixato nuovamente agli Hansa, ma con più tensioni interne rispetto alle opere precedenti. Il video di Stripped è girato in una Berlino oscura e decadente dove la stessa band, memore della lezione industrial, sincronizza il suono prendendo a mazzate un’auto in un deposito accanto agli studi e infrangendone vetri e carrozzeria.
È proprio Wilder, che esce dal gruppo a metà anni 90, a riflettere sul soggiorno berlinese e dichiarare, sempre nella biografia, che:
Non è facile dire quanto stare ha Berlino abbia effettivamente influenzato il sound dei nostri dischi, ma abbiamo di sicuro visto Martin uscire dal suo guscio in questo periodo. Era come se dovesse fare i conti con qualcosa, essendo stato un adolescente timido e riservato. Frequentare club e bar è diventato una routine e abbiamo visto tutti un lato diverso di Martin una volta lasciato libero.
— Alan Wilder
Insomma, sperimentazione senza limiti, voci che si fanno più profonde complici di una ritrovata introspezione, contaminazioni elettroniche complesse, ampliamento del parco strumentale che fa scoprire nuove sonorità e un clima in grado di dare una prospettiva esistenziale inedita a chi lo vive, sono tutti germi di una musica basata sui valori del presente e su un’atmosfera unica, nonché su una variegata disponibilità di alcol e droghe varie, almeno così vogliono le leggende più maledette.
E tutto questo non basta ancora. Non va dimenticato che Berlino è stata già agli inizi degli anni 70 un simbolo, il concretizzarsi di un’opera rock fondamentale: quando Lou Reed concepisce Berlin, egli stesso è sul punto di spezzarsi e nella composizione affronta una catarsi, passa attraverso il fallimento umano e la tossicodipendenza raccontando senza veli i suoi drammi più intimi, ambientando il capolavoro non nella sua New York, ma nella lontana città tedesca. Ancora una volta non è il caso a calamitare l’attenzione, ma un paese simulacro della divisione tanto quanto è lacerato l’animo del creatore, senza dimenticare i riferimenti a Kurt Weil o nuovamente a Bertold Brecht, tra dialoghi e monologhi, delicate emozioni e ruvide paure. Si passa dall’inserimento di un lamento di bambini all’abbattimento dei confini tra generi, dove il rock arriva ad abbracciare i vertici espressivi del jazz, costellato di recitativi e senza tuttavia dimenticare le metriche canoniche del pop. Già un anno prima della pubblicazione, John Cale suona al pianoforte la title track al Bataclan di Parigi, sintomatica unione di due mondi separati per pregiudizio, quello del rock e quello dell’intellighenzia musicale contemporanea.
Poi arriva il 1989, la storia si spacca e Berlino stavolta non si spezza: si unisce e rinasce.
È in questa fase tanto delicata, la fine di un decennio e l’inizio di una nuova era, che un’altra band approda in città cogliendo l’occasione per reinventarsi e respirare a pieni polmoni un futuro ormai imminente. Gli U2 acciuffano l’ultimo volo diretto in Germania Est, ultimo in quanto lo Stato all’indomani non sarebbe esistito nemmeno più sulle cartine, proprio per realizzare la musica del nuovo mondo. Il loro obiettivo inoltre è cercare di trovare uno stratagemma per costruirsi delle maschere che consentano loro di dire tutto ciò che pensano, tutelandoli al contempo, un po’ come riassumeva Oscar Wilde nel suo aforisma “Datemi una maschera e vi dirò verità”, per non finire, come capitato ai Beatles, inglobati e soverchiati dal loro stesso pubblico durante le esibizioni dal vivo.
Quando Bono si trova a bighellonare per le strade del vecchio settore orientale, lo colpiscono le luci ultraviolette nei grandi casermoni: simbolo di supermercati e discoteche nell’Europa conosciuta, gli viene raccontato che qui servono a far crescere piante e fiori nella semioscurità. E il collegamento con un brano come Ultraviolet (Light My Way), decima traccia di Achtung Baby, è immediato.
Quando il quartetto irlandese arriva agli Hansa, li trova praticamente decaduti: non conservano lo smalto dei tempi di Bowie e compagnia, ma il loro sound resta unico e così l’atmosfera straniante. Tra queste mura nasce One, quella che il giornalista e scrittore Bill Flanaghan definisce una delle canzoni più strutturate mai scritte dalla band, con una collaborazione straordinaria di tutti e quasi frutto di un’ispirazione ultraterrena. Inoltre, il disco in questione è solo l’incipit della trilogia che segna una brusca virata nella storia del gruppo, la sua reinvenzione totale. Quando viene pubblicato, è comprensibile che i tempi dell’albero di Joshua e dei rimandi a Elvis siano solo un ricordo: per gli U2 inizia una nuova era e per tutta la storia della musica sono iniziati gli anni 90, con tutto ciò che ne consegue. Bono e compagnia intercettano i tempi andando nell’unico posto dove è possibile vedere il futuro e assaporare il gusto del cambiamento prima che altrove.
Inoltre, nello stile creativo berlinese, intuiscono che le vecchie utilitarie orientali, scatolette con le ruote, una volta ridipinte e dotate di luci, possono stare benissimo su di un palco e trasformano le Trabant in parte della scenografia del mastodontico ZooTv Tour: più che una maschera, un teatro intero. Per trovare un numero sufficiente di vetture, intraprendono un viaggio dall’altra parte dell’ormai infranta Cortina di Ferro, fino a Chemnitz, sede della fabbrica. Sempre a Berlino viene anche concepita la linea melodica di Numb, debito ancora dei Kraftwerk secondo The Edge, della città è quindi figlio anche il successivo Zooropa, passo ulteriore nella direzione sperimentale.
Dall’Inghilterra agli Stati Uniti, rimbalzando per Australia e Irlanda, la forza attrattiva di Berlino non sembra avere confini e non è di certo limitata da centinaia di chilometri di muro. Non bastano poi nemmeno le Alpi per frenare il suo richiamo su alcuni artisti della penisola che, al momento giusto, godono qui una venerazione maggiore che in patria, salvo poi rivelarsi dei vati per i decenni a venire.
Tra le strade di Kreuzberg si incontrano infatti Massimo Zamboni e Lindo Ferretti, nucleo fondatore dei CCCP. Zamboni stesso nel libro Il mio primo dopoguerra, racconta:
Un’autostrada prodigiosa e nuova, questa che parte come Modena-Brennero e s’infila fino a Nord. Il nostro coetaneo conterraneo Piervittori Tondelli ne sa decantare gli scopi al meglio, interpretando i rimuginii di tutta una razza di viaggiatori sentimentali: è l’autobahn più meravigliosa che c’è perché se tu metti lissù e hai soldi e tempo in una giornata intera e anche meno esci sul Mare del Nord, diciamo Amstredam, tutto senza fare una sola curva, entri a Carpi ed esci lassù. Così che Carpi diventa periferica a Berlino.
–Massimo Zamboni
Allo stesso modo, Garbo crea una mitologia decadente e romantica, Franco Battiato e Paolo Conte distillano poesia su luoghi come Alexander Platz, tutto al confine nebuloso tra mitologia e vita vissuta, contribuendo a far nascere in patria la venerazione per la lontana comunità tedesca, meta di artisti, punk, esponenti della sottocultura dark wave e semplici curiosi.
Oggi, per quanto la Germania assorba inevitabilmente le influenze internazionali, non vuol dire che non esistano prodotti del clima sociale e artistico della sua capitale, e di una storia tanto culturalmente vivace. Tra questi, spicca Peter Fox, che con il suo esordio solista Stadtaffe supera il milione di copie. Lui arriva da studi musicali, pianoforte e corno da caccia, con una formazione in pedagogia, e racconta la vita nelle strade della sua metropoli, coi contrasti fatti di risse e vicoli malfamati, ma anche di cosmopolitismo e bellezze scoperte per caso tra i palazzi. È l’essenza dello spirito berlinese più positivo che si fa musica col riff “Wenn’s dir nicht gefällt, mach neu!” (“Se non ti piace, fallo d’accapo!”). Compaiono poi le melodie orecchiabili e l’ironia pungente di brani che prendono le mosse dal punk-rock dei Die Ärtze, in contrasto con la durezza professata dai Rammstein, autori di un omaggio proprio ai Depeche Mode con una cover di Stripped: il video è inoltre provocatoriamente incentrato sul film Olympia, dove Leni Riefenstahl celebra le Olimpiadi berlinesi del 1936. La band raccoglie l’eredità delle sperimentazioni industriali quando si forma, a metà anni 90, creando un connubio tra il rock più pesante e l’elettronica, con testi interamente cantati in tedesco in grado di superare i confini nazionali e show pirotecnici (nel vero senso della parola, visti i lanciafiamme uniti al muro sonoro). Ultima, ma non meno importante, la lezione dei Wir Sind Helden, uniti dalla voglia di fare bella musica e divertirsi e capostipiti di quella che viene definita la Neue Deutsche Welle (la “nuova ondata tedesca”, una new wave tutta germanica), in favore di un recupero della lingua madre a fronte dell’inglese, in grado di vendere un milione e mezzo di dischi nel mondo intero.
Berlino diventata poi la casa di un’artista poliedrica come Peaches, arrivata qui dal Canada a sperimentare le sue performance live, confezionare e produrre i propri dischi marchiati a fuoco dall’elettronica e, similmente, le Chiks On Speed riportano i beat elettro e le contaminazioni tra le arti in primo piano, arrivando qui da Monaco a porre le basi dei propri numerosi progetti. Passano qui Supergrass e R.E.M., gli Scorpions, originari di Hannover, celebrano la loro carriera cantando Wind Of Change agli Echo Awards del 2009, in una O2 Arena che pare un’astronave aliena sorta sulle ceneri del vecchio presidio sovietico.
Del resto, se il muro già di per sé non ha impedito uno scambio artistico tanto fiorente, oggi è ancora più semplice per chiunque lo desideri attingere di un pozzo inesauribile di vita e creatività, ancor più calamitante proprio grazie alla sua storia in musica, dalla vivacità dei cabaret degli anni 20 all’importanza ecumenica della Berlin Philarmoniker, passando per tutta la cultura tecno, punk e rock.
Quattro passi a piedi fino alla frontiera
“Faccio quattro passi a piedi fino alla frontiera”: ovvero, i luoghi in musica della città.
Può sorprendere che la capitale tedesca sia una città da scoprire passo dopo passo in ogni suo anfratto, con centinaia di luoghi che portano ancora intriso il ricordo degli artisti che di lì sono passati o di chi s’è portato in patria una foto ricordo diventata poi famosa. È il caso, ad esempio, della copertina di Journeys To Glory degli Spandau Ballet, tra i gruppi presi da una certa ost-filia, come era capitato ai Visage con la loro Moon Over Moscow: sul loro disco infatti capeggia la foto di una prigione della Berlino occidentale.
Questa città non ha un vero e proprio centro, è un reticolo di strade dove ancor oggi sferragliano i tram dell’ex Germania Est e si accavallano i palazzi dell’Ovest. Ha tanti cuori e ciascuno pulsa al suo ritmo dall’alba al tramonto e poi ancora per tutta la notte, non addormentandosi mai quasi avesse paura di mancare un giro di giostra.
La musica si è creata e si crea tutt’ora in ogni dove, nei teatri, pulsando tra i dj set tecno del Berghain fino ai concerti rock sparpagliati in ogni locale, con tanto di una sosta al museo dedicato al culto dei Ramones. Può capitare, la notte, di uscire dalla fermata della U-Bahn a Schlesisches Tor e ritrovarsi in una jam session improvvisata, un connubio di voce soul, variazioni jazz e tamburi, nata in mezzo alla strada e che si gonfia man mano di balli e di vita, in una Kreuzberg illuminata dalle lampade dei ristoranti turchi e che non ha affatto voglia di andare a dormire.
Icona delle sonorità che da qui sono sgorgate e che hanno conquistato il resto del mondo restano sicuramente gli Hansa Tonstudios, sfavillante sala da ballo nel periodo nazista, sorgono proprio a cento metri dal muro, che era possibile vedere dalla sala regia. Dal 1964 sono testimoni della transizione tra rock e avanguardia europea, a iniziare dalle trilogia elaborata da David Bowie che, insieme a Iggy Pop, prende casa al 155 di Hauptstrasse e frequenta spesso l’S036, un locale che esiste tutt’oggi, non troppo lontano da Oranienstrasse.
A proposito di locali, il Sound è stata, fino a quando un incendio non l’ha distrutta negli anni 80, la discoteca frequentata da Christiane F., tra i vertici della letteratura con la sua cruda rappresentazione della città e dei suoi volti più nudi con Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Il muro tuttavia resta il simbolo maggiore e non solo per la divisione che rappresenta. A pochi passi da lui, nel settore occidentale, Michael Jackson suona creando quasi un incidente diplomatico quando, saputo che a Est molta gente si è assiepata accanto al confine per ascoltarlo, si volta per meglio far sentire la sua voce. Una volta crollato, sono i Pink Floyd a festeggiare l’unione a Potsdamer Platz, nell’estate del 1990, con la partecipazione di una moltitudine di artisti internazionali.
Sulle rovine di quello che fu non poteva non infiltrarsi il sound degli Einstürzende. Già nell’inverno del 1989, suonano per la prima volta nell’altro settore, a Lichtenberg, e il risultato è un documentario straordinaria testimonianza della transizione e dell’unione dei due mondi, Elektrokohle (Von Vegen). Si esibiscono inoltre nel 2004 al Palast Der Republik, simbolo del potere della DDR, poi raso al suolo per far posto a un bel praticello dove passeggiare sereni, confezionando anche in questo caso un documentario di rilevante importanza.
Berlino è tutto questo, ma non basterebbe un tomo intero per trascrivere aneddoti, sensazioni, collisioni di mondi diversi che qui stridono e stringono sodalizi: è una città da vivere intensamente e respirare per capire quanto profondi possano essere i suoi influssi.
L’unica certezza è che, figlia del cambiamento,
porti il cambiamento stesso in ciascuno di noi.
Articolo originariamente pubblicato sulla rivista Late For The Sky (anno XIX, n. 103).